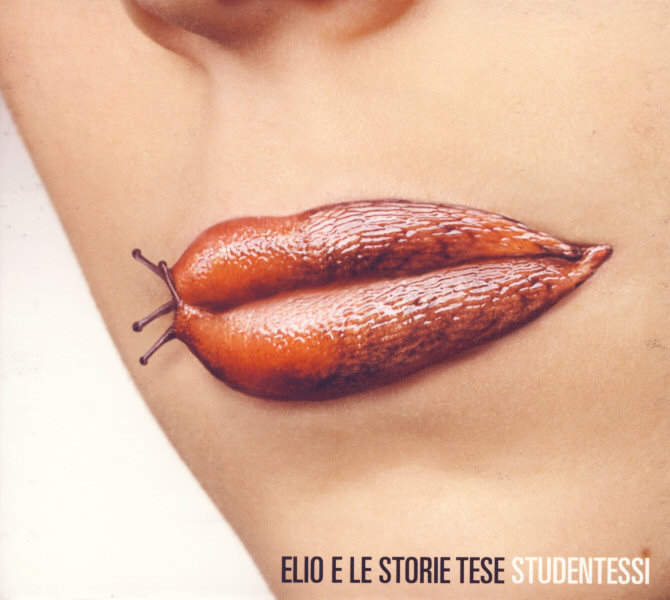A tutto quello che segue premetterei che la tecnica, quando si studia uno strumento musicale, è imprescindibile e va esercitata. Altrimenti non si sta studiando quello strumento. In effetti cos'è la tecnica? Altro non è che la capacità di fare ciò che si vuole con lo strumento. Di averlo sotto controllo. È la capacità di saper fare con il proprio corpo i movimenti e i gesti necessari per utilizzare lo strumento.
L'aspetto tecnico va di pari passo con quello legato ai 'linguaggi', creando a volte confusione anche in personaggi apparentemente (e forse per davvero) preparati. Si tratta di due facce della stessa medaglia (la medaglia sarebbe il saper suonare lo strumento), ma sono pur sempre due cose ben distinte. Quindi facendo un discorso estremo si potrebbe trovare chi sa fare tutto con lo strumento (tecnicamente) ma non lo può realizzare perché non ha assimilato un certo linguaggio, e quindi di fatto non sa cosa dire, e d'altro canto chi ha interiormente acquisito il linguaggio musicale ma non è in grado con il corpo di trasportare sull'oggetto le idee, resta inerme come il primo.
Ora, sul primo caso c’è da dire che raramente, anzi mi verrebbe da dire mai, si sono visti musicisti equipaggiati di tecnica strumentale disarmante ma incapaci di realizzare una qualsivoglia musica. Del resto per poter acquisire questa tecnica di cui parliamo, un po' bisognerà aver suonato, quindi almeno gli esercizi si sarà in grado di effettuarli. Si può affermare con certezza invece che ci siano tanti suonatori bravissimi che poi si mostrano carenti su alcuni determinati generi e stili musicali che evidentemente non hanno compreso a fondo, pur riuscendo in molte situazioni ad imitarli in maniera più che accettabile.
Prima ero una sorta di radar, cioè cercavo sempre di capire la musica per poi suonarla bene... capirla? Ma la devi sentire la musica! Ti giuro che per tanti anni io ho filtrato attraverso il cervello le cose perché era l’unico modo “sicuro” di farle bene. (Michele Luppi)
La tecnica dello strumento è una e basta. Chiaramente se si nota che in certi ambiti vengono utilizzate prevalentemente particolari tecniche e ne vengono tralasciate altre, si potrebbe essere portati a credere che vi siano più tecniche diverse, ma è solo un accorgimento adottato in fase di catalogazione e di suddivisione dei vari 'reparti'.
Ci sono vari livelli di difficoltà tecniche, che possono essere affrontati o meno (e in modi diversi) a seconda di quello che si vuole fare. Ad esempio si potrebbe dire che Paolo Conte e Donald Fagen suonano bene, pur con tecnica scarsa, e se ne farebbero ben poco di tecnicismi particolari e funambolici per i generi che suonano. Certo, ho citato due autori di canzoni e non due pianisti, ma l'argomento resta valido: hanno tecnica sufficiente per ciò che debbono eseguire. Aggiungo anche che sono due dei più stimati da parte mia, onde evitare che si pensi che io con la frase precedente volessi screditare per spasso due monumenti della musica del '900.
Si capisce fin da ora (per i nomi che ho richiamato) che si parlerà di tecnica del pianoforte e non di uno strumento qualsiasi. Il pianoforte è lo strumento che conosco meglio tra i tanti esistenti. Gli approcci allo studio di questa tecnica sono svariati, non li conosco tutti ed il tema è senz'altro alla portata degli insegnanti di pianoforte (perché è il loro lavoro quindi io umilmente do per scontato che sappiano quello che fanno, visto che questa supposizione in tal frangente mi fa comodo per poter accusare delle persone di imperizia), mentre non mi ascrivo alcuna competenza e tanto meno delle qualifiche, ma solo il diritto di mettere per iscritto le mie idee. Comunque esaminerò due atteggiamenti verso lo studio del pianoforte.
Il primo consta nell’applicarsi su esercizi ripetitivi e “di base” (diciamo in stile Hanon per capirci o per fare capire a chi ha suonato il pianoforte con piacere e continuità per un periodo non troppo risicato. Gli altri mi aspetto che abbiano abbandonato la lettura già prima di arrivare qui) ed è sicuramente noioso per molti. In verità, non ho altro da dire, incluso un eventuale mio sbilanciarmi sullo stimare buona o no la redditività di un metodo del genere. Di manuali al livello di Hanon ve ne sono a miriadi io credo; ho l'impressione che siano tutti inutilizzabili senza un insegnante e in ogni caso senza il supporto e l’affetto di una guida più esperta. Di fatto, ogni pianista incontrerà le proprie personali difficoltà durante il percorso e uno dei compiti del buon insegnante dovrebbe essere anche quello di curare i problemi più evidenti selezionando, dall'Hanon del caso, la pratica più idonea per tentare di avviare una manovra correttiva. Ma suonare un manuale tecnico dall'inizio alla fine mi pare una cosa folle oltre che stancante ed inutile. Probabilmente questi libri si addicono a chi è già alle prese con altri studi tecnici e, notando l'emergere di specifiche criticità, desidera curarle con un intervento mirato.
Il secondo e ultimo metodo che posso enumerare ha un nome e un cognome ben precisi: Carl Czerny.
E qui viene il bello.
Ora, Czerny è stato allievo di Beethoven (le cui sonate per pianoforte verranno ricordate in futuro come uno dei più alti picchi raggiunti dall’umanità nell'800 insieme alle equazioni di Maxwell) quindi l'opinione che dovrà emergere di lui non potrà che essere positiva e il suo operato, molto ossequiosamente, non si discute. Ma non deve neanche passare per l'anticamera del cervello di poterlo fare. Detto questo, i difetti del suo metodo legati a carenze di tecnica sono dovuti al fatto che esso è risalente a 200 anni fa e in generale vale la regola che nuovi linguaggi danno spazio alla nascita di nuove tecniche. Quindi l'odierna tecnica del pianoforte (che comprende anche la capacità di suonare il blues e tutto ciò che è stato inventato dopo) non è la stessa diffusa nell'800 a Vienna. Certo mi si potrebbe obiettare che più in alto ho scritto chiaramente che la tecnica dello strumento è una. Io però non sono un musicista, né un musicologo, né uno scrittore e tutte queste lettere le scrivo nel corso degli anni talvolta perdendo la linea dell’orizzonte di ciò che faccio.
Sintetizzando, diciamo che la tecnica è una sola e si amplia grazie ai nuovi generi (si amplia grazie all’aumentare del numero dei linguaggi, i quali godono di una crescita molto più evidente), si espande quindi, ma che con Czerny si suona ancora quasi tutto. E si suona bene, aggiungo. In mia modesta opinione credo che oggi per suonare qualcosa che non sia musica classica basti avere nelle mani la tecnica di Czerny fino al libro 636, ma seriamente, non come lo suono io... il 740 è anche troppo. Voglio dire: se il metodo Czerny è utilizzato da 200 anni avrà qualcosa di buono, no? Tutti i pianisti bravi che conosciamo oggi e che sono venuti dopo, hanno studiato lì. Se arriva qualcun altro e propone la novità, ottimo! Dovremo però attendere almeno 200 anni per poter verificare chi è durato di più tra i due. Prima sarà difficile dirlo perché solo la storia potrà darci la risposta più credibile.
La caratteristica di Czerny di essere strettamente legato alla classica tradizione viennese, apre la porta ad altre problematiche di carattere ibrido tra il tecnico e il musicale. Inevitabilmente gli studi formano l'allievo anche musicalmente, coinvolgendolo sul piano del famoso “linguaggio” di cui discutevo prima, e il linguaggio di Czerny non contempla quelle particolarità che poi rischiano di spiazzare il pianista. Intanto tutti bravi a suonare in sol e in re (maggiori), ma appena c'è un pezzo in re bemolle ti voglio vedere a leggerlo e suonarlo con la stessa disinvoltura. Ma in effetti la musica in re bemolle è molta meno che quella in re, quindi diviene conveniente studiare nelle tonalità che si utilizzano di più e lasciare in secondo piano le altre. Inoltre sono quasi tutti in 2, 3 e 4 quarti e pensati per essere suonati con un metronomo in 4. Mettere il metronomo solo sul 2 e sul 4 crea spesso delle difficoltà.
Ecco, secondo me questi problemi non sono strettamente tecnici ma dipendono dal genere musicale in cui si calano gli studi. Ci sarebbe poi da considerare che l’elevato numero di studi in poche tonalità contribuisce a rendere la musica di successiva composizione monotonale e in ogni caso spesso limitata a poche tonalità, quindi si crea un piccolo circolo da cui sembra difficile uscire.
Ma allora tecnica e linguaggio sono collegati? Certo che lo sono! Inevitabilmente impari sempre entrambe le cose ma in misure diverse; in questo caso ti sbilanci sul classico, ma come detto prima l'alternativa per evitare del tutto ogni genere è fare cose noiose (e anche qui non sono sicuro che si sia esuli da condizionamenti sul linguaggio).
Il punto critico quando si parla di Czerny emerge quando si arriva a parlare dell’op. 740. Intanto bisognerebbe capire cosa significa op., cioè se significa opera oppure opuscolo. Questo non me l’ha mai detto nessuno, ma non è nemmeno tanto significativo.
L’op. 740 è, per un amatore, a dir poco frustrante. Velocità assurde per musiche monotone che si impastano nel cervello.
Per mettere al posto giusto le note, io devo battermi il tempo coi piedi e con la testa, ma addio disinvoltura, addio serenità, addio musica. La musica che proviene da un organismo equilibrato è lei stessa il tempo ch’essa crea ed esaurisce. Quando la farò così sarò guarito. (Italo Svevo)
Io credo che oltre ad una difficoltà tecnica sulle capacità delle dita (che prima o poi si manifesta e forse a tratti potrebbe essere già risolta ed esaudita) ci sia da prendere in considerazione la pesantezza di certe musiche che devono affrontarsi, perché tutti quei sedicesimi a 120 bpm sono tante note… tantissime! Si rischia di non riuscire più a dare un significato alla musica e tanto meno risulta possibile pensare alla stessa mentre la si suona. Bisogna decidere se sentire le note o sentire le frasi, quando si suona veloce.
Back in bebop, everybody used to play real fast. But I didn't ever like playing a bunch of scales and shit. I always tried to play the most important notes in the chord, to break it up. I used to hear all them musicians playing all them scales and notes and never nothing you could remember. (Miles Davis)
Miles Davis non riusciva a suonare veloce perché doveva sentire tutte le note, almeno così diceva, una per una. Pensare quando si suona è un argomento spinoso, che non si tratterà qui, ma vorrei dire che è molto difficile pensare a tanti sedicesimi velocissimi quando si suona, non resta più il tempo di dare un senso a tutte queste note.
Così mi soffermo sulla velocità dei brani di Czerny la quale mi porterà poi a fare un'altra considerazione. Per suonare a certe velocità, a parte disporre di uno strumento adeguato, è anche necessario esercitare tante volte. Qui stiamo solo parlando di acquisire con il corpo umano una capacità meccanica di fare qualcosa, siamo ben lontani dal senso della musica. Per una persona che non è un professionista, non è un musicista insomma, la cosa diventa presto alienante. Tanto tempo, banalmente, molti non lo hanno da dedicare, per le ragioni più svariate. Ci si potrebbe allora chiedere: è meglio fare poco bene o fare tanto male? Eh sì, perché se per fare bene uno studio ci si deve rimanere tanto tempo sopra, conseguentemente se il tempo è risicato si suoneranno pochi studi. E allora si perde da un’altra parte inevitabilmente. Fare per un anno un singolo studio che senso ha? Forse a volte sarebbe opportuno e conveniente ritornare indietro a materiale tecnicamente più semplice? Riprendere brani più facili e farne di più per ritrovare anche un po’ di soddisfazione. L’importante, probabilmente, è darsi degli obiettivi e avere chiaro dove si vuole arrivare.
Non avrei mai voluto darmi degli obiettivi in termini musicali; a me la musica piace, è per questo che la pratico. Mettere delle scadenze e introdurre obiettivi sarebbe limitante, anche se produrrebbe risultati tangibili (beh che sarebbero tangibili ho dei dubbi...) e migliori. Ma se un giorno non ho voglia di esercitarmi su uno studio di Czerny, io non posso obbligarmi a farlo perché tra un mese dovrò suonarlo a 160 bpm, non esiste proprio. Il pianoforte potrebbe non avere la priorità, io non sono un professionista dello strumento e mai lo sarò. Io rivendico il diritto di fare le cose a cazzo di cane, perché fare le cose professionalmente è il sintomo di un malessere generale e diffuso nella nostra società dove essere professionali e specializzati è più importante che essere persone virtuose e sentimentali. Si dovrebbe puntare a essere persone migliori integralmente, il che non vuol dire per forza fare una cosa molto bene e in modo professionale e magari avere carenze gravi in altri ambiti della vita.
Diversi metodi di insegnamento dello strumento vanno di pari passo con diversi generi musicali. Non ritornerò sul tema del jazz già trattato in un altro articolo in precedenza (anche perché ormai il tempo stringe), riporto solo una considerazione presa da un forum e di cui non ricordo l’autore.
Fai un anno di jazz e poi torna a fare il classico.
Ti farebbe capire, da una parte che probabilmente non sei ancora pronto ma, da un'altra, inizieresti a seminare nella direzione che poi potresti riprendere più avanti, ché la semina nel frattempo inizierebbe a germogliare
Cerco di spiegare meglio il mio precedente intervento. Ci sono persone che nascono e sanno quello che vogliono fare e soprattutto quello per cui sono portati e sono in grado di fare. Nel nostro campo (pianistico, NdR), quelli che hanno dentro e sanno ritrovare fantasia, creatività, memoria (!) per cui diventa facile cimentarsi senza ausilio di canovacci, spartiti, ecc. e altri che invece ne hanno bisogno e addirittura non gliene frega niente di essere "schiavi" di uno spartito anzi lo preferiscono. A queste diverse persone vanno bene maestri e scuole che in qualche maniera siano consoni a quello che loro vogliono e sono, rispettivamente diversi in un caso e nell'altro. Poi ci sono persone che non appartengono nè all'una nell'altra delle categorie di cui detto. Ecco secondo me costoro, devono avere il coraggio di seguire strade proprie loro, tipo il percorso sghembo che ho consigliato, diventando anche progettisti dei loro percorsi e operando scelte difficili che neppure sono comprese dai più.
In calce, ancora delle riflessioni prese in prestito da internet sull’utilità dell’op. 740. Ho sinceramente il terrore che la conversazione che riporto scomparirà prima o poi dalla rete. Io la copio tale e quale perché è esilarante, oltre che trattarsi di un buon esempio di come si svolgevano le bizzarre conversazioni da forum online. Poi, soprattutto, parla di Czerny e della sua utilità per poter in prospettiva affrontare gli studi di Chopin.
Onaocn: Il discorso è sempre lo stesso, da un parte la cultura musicale implica la lettura di molto materiale, dall'altra vi è la necessità di arrivare a un compromesso accettabile tra reali possibilità del pianista.
Visto che si parla di Clementi, ebbene come per Czerny se non si hanno gli studi sulle 5 dita e quello sugli arpeggi almeno a 140 di metronomo a quartina senza alcun problema, gli studi di Chopin non sono eseguibili.
Si è anche accennato all'ampiezza della mano e alle peculiarità personali del pianista, tutto vero eccezioni comprese ma, rimane che chi non ha superato i primi tre studi di Czerny op. 740 al metronomo sopra indicato, poiché è necessario andare per gradi (prima ancora scale e arpeggi allo stesso tempo), difficilmente potrà conseguire risultati degni di nota su studi come quelli dell'autore polacco, assumendo rischi anche seri.
E qui tratto brevemente il fattore pianistico insito nello sviluppo tecnico del giovane pianista, detto che le potenzialità naturali sono la priorità, non è da escludere la conoscenza diretta del lavoro pianistico sia come approfondimento della nostra struttura fisiologica atta a trarre le migliori performance dal compromesso esecutore/brano musicale sia di ordine strutturale/compositivo e stilistico.
Nel primo caso si potranno dare particolare rilievo all'"attacco del tasto" e a tutte le sue innumerevoli varietà di affondo e velocità di esecuzione nel rispetto della propria fisiologia e assoluta elasticità, nel secondo l'analisi del brano, rilevante ai fini della prassi esecutiva, dello stile e della memorizzazione.
RaffaeleMJ_91: Non si può parlare in termini certi... io non ho affrontato l'op.740 di Czerny ma suono regolarmente gli studi Op.10 no.12, Op.25 no.1 e Op.25 no.12 e sto per iniziare l'Op.25 no.9.
Penso che l'unico discorso valido sia quello riguardante le possibilità concrete del pianista, a prescindere da repertorio e altro... credo che gli studi di Chopin in cui effettivamente il bagaglio tecnico faccia la differenza (ovviamente non intendo dire che i principianti possano suonare tutti gli altri, ma comunque mi riferisco ad un livello medio/alto) siano i nn.1,2,4,8,11 dell'Op.10 e i nn.4,6,10,11 dell'Op.25. Questa è la mia opinione.
Ciao a tutti!
Onaocn: Ci vuole dire con questo che lei è uno dei pochi super fortunati che non ha passato pianistico su altri studi, avendo subito studiato gli studi del musicista polacco? Buon per lei.
Giusto per capire meglio la sua caratura pianistica, potrebbe gentilmente dirci a che metronomo esegue gli studi op 10 e 25 n 12?
Cordialità.
RaffaeleMJ_91: Grazie per il "lei" ma se ne può anche fare a meno. Grazie anche per il tono sarcastico, non fa altro che confermare il mio pensiero: con i preconcetti non si va da nessuna parte, soprattutto in musica. Innanzitutto lei dice che io non ho passato tempo su altri studi: mai detta una cosa del genere, lei la vede forse scritta? Ho passato ore e ore sull'Op.299 di Czerny ad esempio ma ho evitato l'Op.740 (non per presunzione nè altro, semplicemente passati). Dopo questo chiarimento necessario passiamo a Chopin: eseguo l'Op.25 No.1 al metronomo scritto, cioè intorno al 100 la semiminima. L'Op.10 no.12 sono ad un buon 145 la semiminima e il no.12 lo faccio a poco meno di 70 la minima ma è anche relativamente poco che l'ho studiato. Può anche rimanere nella convinzione per cui se non si studia l'Op.740 non si può matematicamente studiare Chopin, faccia come vuole! Applicarsi nella tecnica globale del pianoforte, cioè sulla spinta dal basso, sul polso vuoto, sul braccio molle, sul peso e sullo scappamento, sulla tecnica stretta di dita, serve molto più che studiare male gli studi. Conosco gente che suona Czerny a velocità atomiche rischiando di sfondarsi i tendini ogni 2 secondi e producendo un suono freddo e inespressivo. Liberiamoci dei preconcetti! Almeno nell'arte!
Un saluto
Onaocn: Evidentemente o ha letto male e male interpretato i miei precedenti o forse mi sono spiegato male, nessuna intenzione di recarle alcun sarcasmo, poi.
Ho parlato dell'op. 740 di Czerny perché nella prassi consolidata di almeno un secolo viene ritenuto un bagaglio indispensabile. Per intenderci, questo non vuol dire che si possa arrivare agli studi di Chopin per altre vie.
Nonostante ciò, in genere si pensa che chi non ha realizzato i primi tre studi di tale opera almeno a 140 la quartina di metronomo, non possa accedere alla professione pianistica e chi non li esegua almeno a 160 alla quartina ha preclusi i quartieri alti di detta professione.
Dal momento che detti studi sono in programma per il compimento inferiore, questa è un’altra ragione pratica per cui vengono tenuti particolarmente in considerazione.
Mi permetta: la parola spinta non esiste in nessuno metodo atto a sviluppare una supposta tecnica pianistica. Non esiste né dal basso né dall'alto e anche se qualche pianista eccezionalmente dotato lo fa raramente, per i più sarebbe assai dannoso. Peso e spinta sono antitetici, contrari forse denotano una certa confusione in atto nel mondo pianistico, certo non professionale.
Esegue gli studi mediamente intorno a 140 alla quartina, poco per eseguirli in pubblico peggio ai concorsi ma, sempre cosa degna e apprezzabile. Il fatto che altri abbiano mezzi superiori e li eseguano a tempi più altri così come dovrebbe essere 150, 160, 176, non vuol dire che si romperanno l'osso del collo ma, solo che hanno doti eccezionali, altrimenti Pollini dovrebbe essere già defunto da tempo...
Cordialità.
RaffaeleMJ_91: "uno dei pochi super fortunati che non ha passato pianistico su altri studi". Forse prima di scrivere bisogna comprendere il significato di quello che si dice. Poi: non è da concerto o da concorso eseguire uno studio al metronomo scritto sulla pagina pentagrammata (l'Op.25 no.1 lo eseguo al suo tempo). Benissimo lei deve essere veramente un cultore del pianoforte. Per quanto riguarda l'op.10 no.12 e l'Op.25 no.12 ho precisato di averli da molto poco in repertorio e che li sto ancora studiando quindi posso anche darle ragione che non vincerei il Concorso Chopin di Varsavia con quelli ma la precisazione è alquanto inutile perchè da per scontato che oltre un certo limite sia impossibile arrivare. Ancora lei dice cosa sbagliata sulla spinta: la spinta esiste soprattutto nello studio degli accordi e della progressione di accordi senza staccare la mano dalla tastiera ad esempio. Se il nome scientifico non è "spinta dal basso" mi scuso ma il fenomeno esiste e si usa anche se pochi lo insegnano. Io ho la fortuna di avere un insegnante che lo insegna.
RaffaeleMJ_91: Ad ogni modo è meglio chiudere la discussione: non ho intenzione di convincerla che il dogma assoluto in musica non esiste così come lei non mi convincerà del contrario. I fatti dicono che si possono studiare gli studi di Chopin anche senza l'Op.740 di Czerny: è libero di pensare che io sia un cialtrone non mi interessa. All'autore del post consiglio vivamente di studiare il no.12 prima del no.1.
Un saluto
Poi in realtà andando avanti migliorava… oltretutto l’intervento seguente del povero moderatore costituisce parte della mia bibliografia per questo brano che ho scritto, poiché citava brani tratti dal libro di Czerny 'Lettere ad una giovane fanciulla sull'arte di suonare il pianoforte'. Era su pianoforum.it e il titolo della discussione era un generico 'Chopin studio 12 op.10'. Chi è interessato se lo cercherà, io per salvaguardarmi l’ho scaricata anni fa per farmi una risata quando mi va di rileggerlo. Sono due pagine.
Concludo ritenendo di essermi dilungato ben oltre le aspettative iniziali e confidando che ogni sedicente insegnante di musica, e particolarmente di pianoforte, si sia posto i sopra riportati interrogativi almeno una volta nella vita.